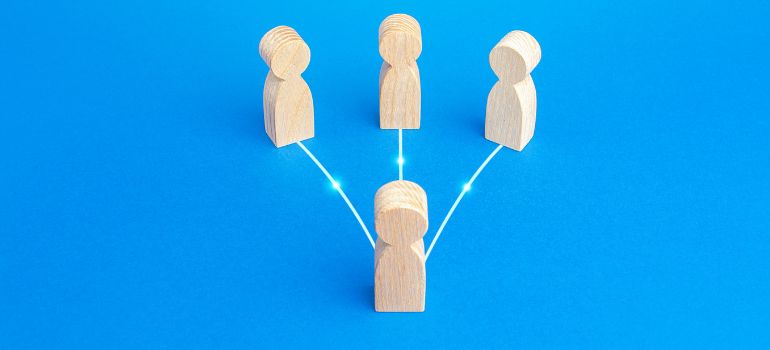Il diritto di proprietà
Cos'è il diritto di proprietà e quali sono e cosa prevede per l'individuo.

Cos’è il diritto di proprietà?
La nostra Carta Costituzionale dedica al diritto di proprietà una apposita norma, contenuta nell’ art. 42. Essa afferma che “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.
Il legislatore costituzionale, dunque, ha abbandonato l’antica concezione individualista della proprietà di matrice napoleonica, assunta dal codice civile del 1865 ed accolta anche dal codice civile del 1942, attribuendo alla proprietà una funzionalizzazione sociale. In essa, infatti, possono essere previsti dei limiti giustificati dal perseguimento di interessi della collettività.
Si pensi alla normativa sulle espropriazioni per pubblica utilità, contenuta da un lato nell’ art. 834 c.c. e dall’ altro nel D.P.R. n. 327/2001, il quale, recependo i maggioritari orientamenti affermatisi negli anni, disciplina le ipotesi di espropriazione per pubblica utilità prevedendo a favore del soggetto espropriato un equo indennizzo, determinato secondo i criteri in esso prestabiliti.
I caratteri del diritto di proprietà
Il diritto di proprietà (art. 832 c.c.) attribuisce al soggetto che ne è titolare la facoltà di godere della cosa, cioè di trarne utilità, ed il potere di disposizione, cioè di cambiarne la destinazione e di costituire diritti reali su di essa. Tali facoltà e poteri sono stati da sempre concepiti come esercitabili in modo pieno, cioè senza limiti (ove non sia previsto diversamente), esclusivo, avendo il diritto di pretendere dai consociati un’astensione dal tenere comportamenti che possano ostacolare il libero esercizio del diritto, e perpetuo, non essendo sottoponibile a termine finale.
Considerazioni critiche al tradizionale modo di concepire il diritto di proprietà
L’esistenza di limiti al diritto di proprietà e la presenza di diverse discipline legislative hanno portato la dottrina a ritenere che vi siano, in realtà, una pluralità di statuti proprietari. Invero, la dottrina (Gugliatti, Allara), già a partire dagli anni 60-70, ha abbandonato la tesi monista che riteneva esservi un solo diritto proprietario, ma ha cominciato a ritenere che il nostro ordinamento prevedesse una pluralità di statuti proprietari e concepisse l’esistenza di una pluralità di diritti di proprietà, distinti gli uni dagli altri.
Anche il tradizionale modo di concepire i caratteri del diritto di proprietà, che trova il suo fondamento nella formulazione originaria dell’art. 832 del codice civile del ’42, ancora vigente, è ad oggi messo fortemente in discussione dall’ esistenza di nuove forme di proprietà. Invero, esigenze di tipo economico e di circolazione dei beni, hanno imposto l’elaborazione di statuti proprietari che non presentano le caratteristiche tradizionali del diritto di proprietà, bensì caratteristiche diverse. Si pensi alla multiproprietà o al contratto di trasferimento della proprietà sottoposto a condizione risolutiva o ancora al trust, la cui struttura diverge dallo schema tradizionale tipico della proprietà.
La descritta situazione di fatto ha messo in crisi non solo il tradizionale principio di tipicità dei caratteri del diritto di proprietà, ma anche il principio di tipicità dei diritti reali. Secondo il suddetto principio i diritti reali costituirebbero un numerus clausus, con la conseguenza che sarebbe precluso ai soggetti privati il potere di creare diritti reali diversi da quelli legislativamente tipizzati o con caratteri diversi da questi ultimi. La ratio di una tale disposizione risiede in esigenze di tutela dei terzi, il che troverebbe conferma nella previsione di tassatività dei diritti reali soggetti a trascrizione.
Tale tesi troverebbe il suo fondamento nell’ art. 2643 e 1372 c.c. La prima disposizione elenca in maniera tassativa i diritti reali suscettibili di trascrizione nei pubblici registri, quindi, a voler dare asilo all’ idea della atipicità dei diritti reali ci si scontrerebbe contro la impossibilità di trascrivere i diritti reali atipici, con notevoli difficoltà per la risoluzione dei possibili conflitti tra diversi aventi causa.
La seconda disposizione, contenuta nell’ art. 1372 c.c., nel prevedere che il contratto ha forza di legge soltanto tra le parti e non nei confronti dei terzi, impedirebbe di opporre ai terzi un diritto reale atipico eventualmente pattuito tra le parti, il che cozzerebbe con il diritto di sequela proprio di taluni diritti reali limitati e della opponibilità ai terzi.
Senonché, la nascita di statuti proprietari distinti dai modelli tipici ha condotto una parte della dottrina attuale a mettere in discussione anche il principio di tipicità dei diritti reali in favore dell’adozione della tesi della atipicità mediante la possibilità di estendere il principio dell’autonomia contrattuale di cui all’ art. 1322 c.c. anche ai diritti reali: l’autonomia contrattuale e la correlativa possibilità di prevedere modelli contrattuali atipici, secondo taluni può essere esteso sino a ricomprendere il potere di individuare caratteri atipici dei diritti reali.

Altro su Codice civile
Approfondimenti, novità e guide su Codice civile